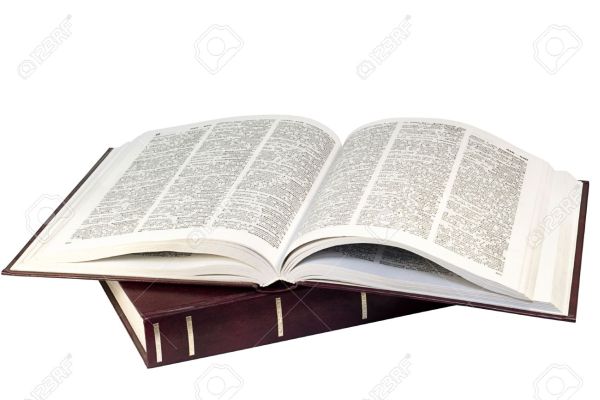La Milano del Dopoguerra; un’amicizia tra due ragazzi, entrambi studenti del liceo Parini di Milano, nata alla fermata del tram 6, direzione Loreto-Duomo, angolo via Petrella; l’idea di un’arte per tutti; un Sindaco “illuminato” che sposa la causa del teatro come “servizio pubblico”. E poi uno spettacolo d’avanguardia che mette in scena una galleria di ritratti di vagabondi la cui unica libertà è la desolazione. E’ così che il 14 maggio 1947 nasce il “Piccolo Teatro” di Milano, fondato da Giorgio Strehler, Paolo Grassi e Nina Vinchi: in cartellone “L’albergo dei poveri”, un testo di Gor'kij in cui la questione sociale esalta l'umanità dei miseri, vagheggiando una loro prossima dirompente emancipazione. Un sogno di rinascita e di rinnovamento dalle ceneri del Secondo conflitto mondiale, che diede un sapore molto programmatico alla messa in scena del Piccolo del ' 47. E nei panni del ciabattino Alioscia, proprio Giorgio Strehler che divenne poi regista stabile del Piccolo.
A dare ancora maggiore solennità all’evento, dopo solo due anni dalla Liberazione, prima dello spettacolo un discorso con cui Grassi ringraziò il Comune, che con il diretto interessamento dell’allora Sindaco Greppi rese possibile il progetto. Lo spettacolo fu preceduto da una Serenata di Mozart suonata dall’orchestra della Scala. Si trattava, infatti, di un evento sociale e culturale di grandissima importanza nella dura realtà del Dopoguerra.
Da un punto di vista culturale, all’epoca in città, i teatri attivi erano il Teatro Lirico, il Teatro Nuovo, il Mediolanum, il Teatro Odeon e il Teatro Excelsior, (dove nel novembre 1946, andò in scena “I piccoli borghesi”, sempre di Gor'kij, spettacolo organizzato da Paolo Grassi con regia di Giorgio Strehler, la “prova generale” della nascita del Piccolo Teatro). Queste sale però erano tutte realtà gestite da privati, cui nel secondo dopoguerra si contrappose la richiesta di un teatro come “servizio pubblico”. Promotori di questa istanza furono proprio Paolo Grassi e Giorgio Strehler. La loro voce fu accolta da un interlocutore privilegiato: il sindaco di Milano, l’avvocato socialista Antonio Greppi: lui stesso appassionato di teatro, sostenne la necessità di una rinascita anche culturale della città.
Nel gennaio 1947, la Giunta municipale deliberò la costituzione del nuovo teatro, assegnando come sede Palazzo Carmagnola, conosciuto anche con il nome di Broletto, in via Rovello 2, sede della Filodrammatica degli impiegati comunali, divenuto negli anni della R.S.I. luogo di supplizi ad opera della milizia fascista Ettore Muti. Lo spazio poteva contare su un palcoscenico di dimensioni ridotte (sei metri di profondità per cinque e mezzo di larghezza) e circa 500 posti a sedere. Il nome “Piccolo Teatro” fa riferimento, da un lato, a questi spazi non certo grandi, mentre dall’altro è un omaggio al Malij Teatr di Mosca (“piccolo” in opposizione al Bolscioi, il Grande Teatro).
Il Piccolo, a gestione municipale, fu insieme il primo teatro pubblico e il primo teatro stabile d’Italia. Accanto a Grassi e Strehler, vero braccio operativo, Nina Vinchi, moglie di Grassi, “la Signora del Piccolo” di cui fu segretario generale e perno centrale della struttura organizzativa, fino alle sue dimissioni avvenute nel 1993.
A questi nomi si aggiunsero poi gli altri membri della commissione artistica, nominati dalla Giunta comunale, che furono Mario Apollonio e Virginio Tosi. Negli anni Cinquanta, anche Eugenio Montale divenne un membro della commissione.
Il Piccolo, a gestione municipale, fu insieme il primo teatro pubblico e il primo teatro stabile d’Italia. Accanto a Grassi e Strehler, vero braccio operativo, Nina Vinchi, moglie di Grassi, “la Signora del Piccolo” di cui fu segretario generale e perno centrale della struttura organizzativa, fino alle sue dimissioni avvenute nel 1993.
A questi nomi si aggiunsero poi gli altri membri della commissione artistica, nominati dalla Giunta comunale, che furono Mario Apollonio e Virginio Tosi. Negli anni Cinquanta, anche Eugenio Montale divenne un membro della commissione.
Dopo le 26 repliche del testo di Gorki, gli altri spettacoli della prima stagione furono “Il mago dei prodigi” di Pedro Calderòn del la Barca, “Le notti dell’ira” di Armand Salacrou, e “Il servitore di due padroni” (meglio conosciuto come “Arlecchino servitore di due padroni”) di Carlo Goldoni, con Marcello Moretti nei panni di Arlecchino, spettacolo destinato ad essere ripreso più volte nella storia del Piccolo, in diverse versioni, alcune delle quali debuttarono all’estero.
Con il Piccolo, nasce non solo una sala per spettacoli dal vivo ma un "Teatro d'Arte per Tutti": anche per questo i prezzi dei biglietti sarebbero stati mantenuti bassi e vi sarebbe stata la possibilità di sottoscrivere abbonamenti e di ricevere sconti nel caso di gruppi. Secondo Grassi, infatti, il “popolo” non rimaneva fuori dai teatri per una questione culturale, ma unicamente per ragioni economiche.
In più di settant'anni di attività, il Piccolo ha prodotto circa 400 spettacoli, la metà dei quali diretta da Strehler, di autori che vanno da Shakespeare ( Re Lear e La tempesta) a Goldoni ( Le baruffe chiozzotte, Il campiello e soprattutto Arlecchino servitore di due padroni), Brecht ( L’opera da tre soldi, Vita di Galileo, L’anima buona di Sezuan), Cechov ( Il giardino dei ciliegi).
Dal 1987 ha una Scuola di Teatro – fondata dallo stesso Strehler, intitolata a Ronconi, attualmente diretta da Carmelo Rifici – che ha diplomato 230 attori. Nel 1986, con lo spettacolo “Elvira o la passione teatrale”, in cui Strehler recitò accanto a Giulia Lazzarini, venne inaugurato il Teatro Studio (in via Rivoli 6), progettato dall’architetto Marco Zanuso. Dal 1991 il Piccolo Teatro di Milano è anche “Teatro d’Europa”, come peraltro riconfermato dall'articolo 47 del DM n. 332 del 27 luglio 2017.
Grassi rimase alla direzione del Piccolo venticinque anni, sino al maggio del 1972.
L’ALBERGO DEI POVERI
Il titolo originale è “Na dne” che in russo vuol dire “Nel fondo”, alludendo ai bassifondi della vita, dove si cade e non ci si rialza più. Il testo ci riporta a quel momento della fine dell'Ottocento in cui la questione sociale consisteva nel rivendicare l'umanità dei miseri e nel vagheggiare una loro prossima dirompente emancipazione, un sogno di rinascita molto significativo per l’inaugurazione del Piccolo.
Questo spettacolo, che riesce a coagulare buona parte della compagnia che per alcuni anni sarà stabile al Piccolo e che avrà le sue punte in Gianni Santuccio, Lilla Brignone e Marcello Moretti, non è un dramma di intreccio, ma una galleria di ritratti di vagabondi. L'usuraio Kostylev ha trasformato una misera cantina in un albergo dei poveri, asilo notturno per senzatetto. Tra gli ospiti dell'albergo c'è Luka, mezzo santo e mezzo ciarlatano, capace di infondere in tutti un po' di speranza o di illusione; e il ladro Vaska, amante di Vasilisa moglie di Kostylev, ma in realtà innamorato della sorella di lei Natascia. Vasilisa cerca di indurre Vaska a uccidere Kostylev per poter vivere insieme. Vaska alla fine acconsente ma con un altro scopo: liberare Natascia dall'odiosa sopraffazione dell'usuraio. Dopo la morte di Kostylev, anche Luka scompare dall'albergo, lasciando i compagni di miseria nella disperazione.
Celebre la frase di Luka, secondo cui: “ La verità non è mica sempre buona, per la gente… Non sempre si può curare l’anima, con la verità…” e che allude alla triste disperazione della realtà.